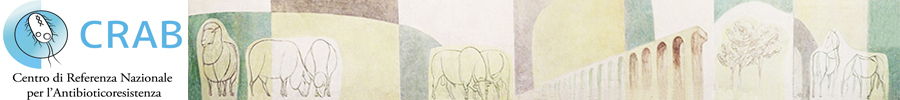Valori di Minimum Inhibitory Concentration (MIC) e Breakpoint Clinici nella pratica clinica
Nei test di sensibilità con metodiche di “diluizione”, si determina la Minimum Inhibitory Concentration (MIC), ovvero la più bassa concentrazione di antibiotico (espresso in mg/L) che previene una crescita visibile di un agente batterico (di un microrganismo). Per scopi terapeutici i valori quantitativi di MIC sono categorizzati come “Sensibili” (talvolta “Intermedi”) o “Resistenti”, attraverso Breakpoint clinici definiti da organismi internazionali di Standardizzazione. E’ utile ricordare che i breakpoint clinici non sono disponibili per tutte le combinazioni di antibiotici, specie batteriche e specie animali, indipendentemente dal tipo di metodica utilizzata (es. Disk Diffusion o Broth Dilution).
In ogni caso, nella scelta dell’antibiotico per la terapia di una malattia batterica, sulla base dell’esito dei test di Sensibilità anche con la metodica di diluizione, si raccomanda di mettere in pratica:
a. i principi dell’uso prudente, evitando per quanto possibile l’impiego di molecole di più nuova generazione e a più largo spettro, riservando ogni volta che è possibile le molecole di CIA e HPCIAs ad un utilizzo di seconda o ultima scelta, basandosi sull’esito del test di sensibilità;
b. le nozioni di farmacologia clinica in relazione all’agente infettivo, alla sede di infezione, alla specie animale da trattare, ed alla farmacocinetica e farmacodinamica dell’antibiotico.
Nella scelta tra le possibili varie classi o subclassi di molecole da utilizzare, può risultare fuorviante e non corretto decidere in base a semplici comparazioni che prendono a riferimento i valori di MIC riscontrati per ogni singola molecola tra classi/subclassi diverse di antibiotici, e mettendoli in relazione al rispettivo valore di breakpoint.
Infatti, i valori di breakpoint possono variare molto tra le classi/subclassi, e dipendono dalle caratteristiche intrinseche e farmacologiche delle molecole stesse, da PK/PD e da studi di farmacologia clinica rispetto ai dosaggi impiegati.
Inoltre, i range di diluizioni presenti nei pannelli commerciali comunemente usati per scopi di diagnostica clinica, e non per scopi di ricerca o monitoraggio, hanno un range variabile ma spesso limitato in numero diluizioni, che spesso è distribuito e “pesato” immediatamente intorno ai rispettivi breakpoint clinici.
Tutte queste informazioni risultano indispensabili anche per valutare se e quando utilizzare in modo appropriato e valido possibili indici come il quoziente breakpoint MIC (QBM) nella scelta della terapia con determinati antibiotici.
Infine, laddove fosse appropriato e corretto, l’indice QBM potrebbe essere ragionevolmente valutato soltanto all’interno di una stessa subclasse o classe di antibiotici, per avviare una terapia che tenga conto in primis dei criteri di cui in a. e in b. soprarichiamati.